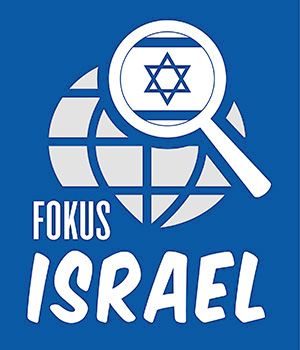Le università come focolai di fede anziché di conoscenza
Da Sacha Wigdorovits
Netflix sta attualmente trasmettendo una divertente serie intitolata “Nero”. Parla di un killer professionista e di sua figlia, che si dice sia l’ultima discendente vivente del diavolo.
La storia si svolge nel sud della Francia alla fine del Medioevo. Tra i protagonisti ci sono i “Büsser”: un gruppo di cattolici fondamentalisti e fanatici che credono che l’allontanamento da Dio sia la causa della siccità e della carestia nella regione. Nel corso del tempo, emerge che questa comunità di Büsser è stata fondata su iniziativa di un arcivescovo assetato di potere. Alla fine, però, i Büsser ne hanno abbastanza anche di lui e lo buttano giù dal balcone della sua cattedrale senza ulteriori indugi.
La serie è una resa dei conti con la Chiesa Cattolica. Essa è accusata di fare appello alla superstizione della gente comune per consolidare il proprio potere e imporre le proprie politiche con promesse apocalittiche e violenza brutale.
Senza volerlo, “Nerone” è quindi anche un’allegoria dei giorni nostri. La Chiesa cattolica è stata sostituita dalle università. Oggi, spesso non insegnano più la conoscenza e il pensiero sobrio, come sarebbe in realtà il loro compito. Al contrario, la fede e il fanatismo vengono promossi per motivi politici.
Questo vale in particolare per le discipline umanistiche. E si svolge da Boston e New York a Zurigo e Basilea e, soprattutto, a Losanna e Ginevra.
Ciò è evidente soprattutto in relazione alla guerra di Gaza, ai palestinesi e agli ebrei (scusate: “sionisti”). Sotto la bandiera del post-colonialismo, i fatti storici e attuali vengono sostituiti da un credo infondato e dai tratti settari.
Come nel caso dei gruppi di boscimani che hanno portato scompiglio in molti paesi europei tra il XII e il XVI secolo, lo stesso vale per questi studenti post-coloniali e per alcuni dei loro professori, naturalmente di sinistra: la colpa della nostra miseria è degli ebrei. Ed è per questo che devono essere perseguitati ed espulsi.
Proprio come la Chiesa cattolica ha osservato a lungo le attività di Büsser – o addirittura le ha incoraggiate – le amministrazioni universitarie di oggi spesso osservano o sostengono attivamente le attività dei loro studenti e di alcuni professori per molto tempo.
Quest’ultimo caso riguarda le università di Ginevra e Losanna, i due maggiori focolai accademici di antisemitismo in Svizzera. Le direzioni delle università hanno interrotto la cooperazione istituzionale con le università israeliane. Che lo abbiano fatto per paura della folla di studenti fanatici o per convinzione personale è irrilevante.
In inglese, l’epoca in cui in Europa le donne venivano bruciate come streghe, i presunti apostati venivano torturati e gli ebrei perseguitati e uccisi è nota come “i secoli bui”. Ci vollero alcune centinaia di anni prima che l’Età dei Lumi sorgesse dopo quest’epoca oscura di superstizione e fanatismo cieco.
Ma anche questo “Secolo dei Lumi” non è stato esente da ricadute in tempi bui. Sono passati meno di cento anni da quando abbiamo vissuto il terrore e il fanatismo barbaro dei nazionalsocialisti in Europa e i “roghi di streghe” dell’era McCarthy negli Stati Uniti, per citare solo due esempi.
Ora stiamo per tornare indietro, in Europa e negli Stati Uniti, verso un’altra “età oscura”. La novità è che questa volta non sono la chiesa o la politica a giocare un ruolo centrale, ma le istituzioni che più di ogni altra dovrebbero promuovere la conoscenza e l’umanesimo invece di alimentare (mis)credenze e fanatismi: le università.
Fortunatamente non è così ovunque, o almeno non nella stessa misura. Ad esempio, le due università finanziate dal governo federale, l’ETH di Zurigo e l’EPFL di Losanna, hanno dichiarato pubblicamente che continueranno a collaborare con le università israeliane. Anche le università di Berna e Zurigo si sono espresse contro il boicottaggio degli istituti di istruzione superiore o dei ricercatori israeliani.
Ma quando la direzione e i professori delle università cedono alle pressioni dei loro corpi studenteschi antisemiti e violenti – o addirittura sostengono attivamente questi gruppi – i cantoni locali dovrebbero porre fine a questo comportamento.
Hanno i mezzi per farlo nelle loro mani. Ad esempio, quando sovvenzionano le università, i parlamenti cantonali possono imporre condizioni chiare sulla gestione dell’università, sui requisiti per l’insegnamento e la ricerca e sul comportamento del personale docente e degli studenti.
Ciò deve includere, in particolare, che le conoscenze accademiche siano insegnate senza un’agenda politica (cosa che purtroppo non è più scontata) e che nel campus universitario siano vietate le azioni politiche che non hanno nulla a che fare con l’università stessa.
Inoltre, va detto chiaramente che le violazioni di queste disposizioni costituiscono un motivo di licenziamento previsto dal contratto per il personale docente che non adempie ai propri doveri, comportano l’esclusione degli studenti trasgressori dall’università in questione e comportano tagli alle sovvenzioni da parte del Cantone.
Questo non ha nulla a che vedere con la limitazione della libertà di espressione. I raduni antisemiti, il bullismo nei confronti di studenti e professori ebrei e le proteste contro la cooperazione con le università israeliane non sono espressione della libertà di espressione liberale. Sono segni di una dittatura d’opinione della sinistra radicale che deve essere combattuta.
Da un lato, perché l’odio e il fanatismo che vengono alla luce non sono diretti solo contro gli ebrei, ma contro la nostra società libera e democratica in generale.
D’altra parte, perché le università non hanno diritto di esistere se sono terreno di coltura per il fanatismo e i credi politici sbagliati invece che mediatori e incubatori di conoscenza, pensiero razionale e indipendente ed etica.
Questo articolo è apparso anche su nebelspalter.ch
Sacha Wigdorovits è presidente dell’associazione Fokus Israel und Nahost, che gestisce il sito web fokusisrael.ch. Ha studiato storia, tedesco e psicologia sociale all’Università di Zurigo e ha lavorato come corrispondente dagli Stati Uniti per la SonntagsZeitung, è stato caporedattore di BLICK e cofondatore del giornale per pendolari 20minuten.
Hai trovato un errore?